Storia della Macroregione Mediterranea
https://youtu.be/Nfd0fkMykeg
Configurazione del Mediterraneo e Preistoria

Introduzione
Circa cinque milioni di anni fa, il Mar Mediterraneo era una vallata profonda e secca che divideva tre continenti: Europa, Africa e Asia, fino a quando un cataclisma fece una breccia nel muro di contenimento dell’Oceano Atlantico ad ovest verso l’odierna Gibilterra.
In un processo lunghissimo una gigantesca cascata di acqua ha inondato l’intero bacino mediterraneo, facendo nascere un nuovo mare.
Analizzando più attentamente la configurazione di questo sorgente Mare Mediterraneo troviamo che è formato da un insieme di mari: il mar Alboran, il Golfo di Lione, il Tirreno, lo Ionio, il mar Egeo, l’Adriatico, ognuno con caratteristiche proprie.
Nell’insieme il Mediterraneo è un mare profondo dai 3000 ai 4000 metri.
Questa profondità permette ad alcune specie di balene di viverci, come anche al pesce spada, al tonno e al delfino.
Il Mediterraneo è un mare piuttosto chiuso. Vi è un piccolo scambio delle acque con l’Atlantico sullo stretto di Gibilterra e con il mar Nero sullo stretto del Bosforo ad Istanbul. All’estremo est, il canale di Suez, sebbene navigabile, è soltanto una comunicazione artificiale con il mar Rosso. Le coste africane ed asiatiche sono aride e piatte, mentre le coste europee, anche se non soggette a piogge pesanti, sono verdi e montagnose, con un clima più temperato.
Il continente africano da sempre si spinge lentamente verso il continente europeo e questo ha causato l’innalzamento delle Alpi.
La conseguente frattura nella crosta terrestre ha formato i vulcani: Etna, Stromboli e Vesuvio in Italia e Santorino in Grecia. Questo movimento verso il continente europeo è anche la causa della attività sismica in questa area.
L’uomo è arrivato piuttosto tardi sulla scena del Mediterraneo. Vi sono tracce dell’uomo di Neanderthal principalmente nelle caverne del Circeo a sud di Roma, nella costa ligure, a Gibilterra, in Francia ed in alcune altre aree. L’arrivo del nostro più diretto antenato, “Homo Sapiens”, si può datare intorno a 100.000 anni fa. Vista la sua attitudine alla guerra, si può legittimamente ipotizzare che l’Homo Sapiens Sapiens ha avuto un ruolo nel processo di estinzione dell’uomo di Neanderthal circa 30.000 anni fa.
Ogni ricorrente era glaciale ha prodotto drastici abbassamenti nei livelli del Mediterraneo, mentre la stessa quantità d’acqua veniva depositata, sotto forma di alti strati di ghiaccio, nelle regioni polari. Questo ha permesso all’uomo primitivo di spostarsi e di popolare molte terre, comprese quelle che in seguito sarebbero diventate isole, una volta che il clima si fosse riscaldato, innalzando di nuovo i mari.
L’uomo primitivo non si è fermato per molto davanti alle distese d’acqua del Mediterraneo.
La curiosità innata dell’essere umano e la sete per l’avventura lo spinsero a costruire zattere primitive e barchette costruite con canne con cui molti popoli hanno remato o si sono lasciati trasportare attraverso le acque, raggiungendo isole come Cipro e Malta 5000 anni fa, formando le basi delle popolazioni odierne. L’uomo ha lentamente popolato tutto il bacino mediterraneo. E in questo speciale e favorevole ambiente mediterraneo ha prosperato.
Caratteristiche e prima storia
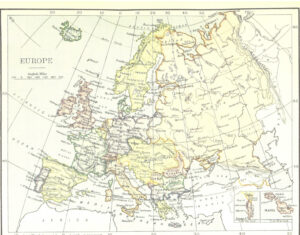
La caratteristica di unione (essere nel mezzo fra terre) del Mediterraneo è indicata esattamente dal nome stesso già in uso presso gli scrittori latini.
Essi spesso lo designarono anche con l’appellativo di Mare internum, in contrapposto all’Oceano o mare esterno, o anche con quelli di Mare nostrum e Mare magnum.
Il Mediterraneo fu da epoca assai remota teatro di un’intensa navigazione: Fenici e Greci lo percorsero quasi in ogni senso.
Il movimento di espansione dei Greci, iniziatosi nel secolo VIII a.C., condusse alla conoscenza dei lineamenti fondamentali del bacino; nel secolo VII certamente il Mar Nero è riconosciuto come mare chiuso, al pari dell’Adriatico; alla fine di quel secolo si riconoscono anche le coste settentrionali del Tirreno e del Mar Ligure (del 600 a. C. circa è la fondazione di Marsiglia).
Poco dopo i Greci raggiungono lo stretto di Gibilterra, dove già assai prima di loro erano pervenuti i Fenici.
La più antica geografia ionica (Anassimandro, Ecateo) conosce già il Mediterraneo come un mare chiuso da ogni parte, in comunicazione con l’Oceano Atlantico soltanto per le colonne d’Ercole.
Le carte del più alto Medioevo indicano figurazioni per diverse ragioni del tutto alterate. Errate sono pure quelle delle carte arabe (p. es.: Edrisi), influenzate del resto da Tolomeo.
La cartografia nautica italiana dà invece, sino dall’inizio del secolo XIV, una figurazione molto esatta di tutto il contorno del Mediterraneo; le rappresentazioni delle carte nautiche sono il fondamento principale per la graduale correzione degli errori tolemaici fatta dai geografi e cartografi.
L’altissimo sviluppo di coste di quasi tutti i paesi mediterranei, la frequenza delle isole, i facili accessi dall’interno a punti innumerevoli di ben riparato approdo, la rarità delle nebbie sono tutti elementi che sin da tempi antichissimi hanno spinto le genti mediterranee al mare. Da ciò gli scambi attivissimi fra le popolazioni rivierasche, mediante i quali economie tipicamente diverse, come quelle dell’Occidente europeo e del Levante asiatico, sono poi venute rapidamente e intensamente a contatto.
Nell’antichità alcuni popoli vivevano principalmente di questi scambi, anche con la diffusione di colonie commerciali e demografiche, poi con l’organizzazione di grandiose unità economiche, culturali e politiche.
Fra Stati indipendenti e dipendenze di varia natura si contano intorno al Mediterraneo non meno di 25 unità politiche.
Fra esse, accanto a complessi di grandiosa mole per area e popolamento, sopravvivono ancora antichi staterelli minuscoli (Andorra, Monaco, S. Marino, M. Santo) e minuscole unità dell’impero britannico (Gibilterra, Malta) o s’insinuano forme rappresentative dell’autonomia di piccole nazioni (Albania), qua e là legate ancora a complessi maggiori (Georgia, Crimea, Libano) o distinte per lingua e tradizioni (Catalogna).
Via via il coordinamento di codeste unità in complessi politici maggiori è di fatto particolarmente vigoroso nel bacino occidentale, dove questi sostanzialmente via via si riducono a tre: il dominio francese (Francia, Marocco, Algeria, Tunisia), il dominio spagnolo (Spagna e Marocco spagnolo) e l’italiano (Italia e Libia).
Per tutte e tre queste antiche potenze è evidente la tendenza all’altra sponda, cioè l’espansione verso le rive meridionali del Mediterraneo situate dirimpetto alla madrepatria.
La frammentarietà mediterranea è ancora assai pronunciata nel restante bacino, al quale si affacciano Stati indipendenti.
Dall’anno zero agli inizi del terzo millennio

I primi cinque secoli d.C. videro le nascenti potenze di Roma e Cartagine contendersi le acque del Mediterraneo. Lunghe guerre che si conclusero con la consacrazione della potenza romana e la distruzione dei Punici. Da allora in poi il Mediterraneo divenne il Mare nostrum e su tutto il suo bacino si irradiò la civiltà e la potenza della Roma repubblicana e imperiale.
In questo periodo il Cristianesimo segna una svolta decisiva nella storia; in poco più di due secoli si afferma nell’Impero romano.
Nel 326 d.C. Costantino trasferì la capitale a Bisanzio (l’odierna Istambul), l’antica città greca che sorgeva sullo Stretto dei Dardanelli, ai confini tra Europa e Asia. Dal quarto secolo i Vandali, una popolazione della Germania, si riversò in Mauretania (attuale Marocco e Algeria nord occidentale). Giunti in Numidia (attuale Algeria Orientale) sconfissero i Romani nel 430. Conquistarono Cartagine nel 430 e organizzarono incursioni in tutto il Mediterraneo.
Nel 395 d.C. l’imperatore Teodosio divise definitivamente l’Impero Romano in due parti che lasciò ai suoi due figli: l’impero d’Occidente, con capitale Milano, e l’Impero d’Oriente, con capitale Costantinopoli (la città greca di Bisanzio che Costantino aveva scelto come capitale).
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente e la stagnazione dei commerci nel bacino occidentale, l’Impero romano d’Oriente (Bizantini), di cultura prevalentemente greca, separatosi dalla parte occidentale, di cultura quasi esclusivamente latina, dopo la morte di Teodosio I nel 395, mantenne intensi traffici marittimi.
Sacro Romano Impero, Regni ellenistici ed espansione islamica

Nell’Alto Medioevo si sviluppò l’impero Carolingio, fondato con l’incoronazione di Carlo Magno a Imperatore romano da parte di Papa Leone III la notte di Natale dell’800.
Dalla frantumazione dell’Impero Macedone sorsero i Regni Ellenistici, tra cui quello Tolemaico in Egitto, quello degli Antigonidi in Macedonia e quello dei Seleucidi in Siria e in Asia Minore.
Nel contempo, nel 7°e nell’8°secolo, l’espansione islamica sconvolse l’intero bacino mediterraneo.
In questo periodo l’unità del Mediterraneo fu propugnata dagli Arabi per mezzo del vasto califfato Abbàsidi, una dinastia che governò il mondo islamico dal 750 al 1258, e poi parte di esso tra il 1261 e il 1517, con capitale Baghdad. Dalle coste del vicino Oriente all’Africa Settentrionale, oltrepassando lo stretto di Gibilterra, l’espansione islamica giunse fino in Spagna. L’Islam, pur fermato a Est dall’Impero bizantino e a Ovest da Carlo Martello, controllava le grandi isole da Cipro alle Baleari, rimase padrone di Siria, Africa settentrionale e Spagna e nella zona meridionale del Mediterraneo fondò centri luminosi di cultura.
Repubbliche Marinare e dominio ottomano

Nel 12° secolo le Repubbliche marinare (Amalfi, Pisa, Genova e Venezia le più note, ma anche Ragusa, Ancona e Gaeta), animate dallo spirito di commercio, arrivano fino al Vicino Oriente, nonostante gli interessi commerciali minacciati dai popoli provenienti dalla penisola araba (Saraceni). Successivamente, sia i contrasti con le marinerie aragonesi sia la crisi dei traffici mediterranei le portarono al declino.
Nel 1453 vi fu la caduta di Bisanzio, nelle mani dei Turchi dell’Impero ottomano. Una fase di declino della vitalità del Mediterraneo venne aperta sia dallo spostamento delle maggiori rotte commerciali verso l’Asia che, dopo la scoperta nel 1492 dell’America, verso l’Atlantico.
Il dominio stabilito sul Mediterraneo orientale dagli Ottomani non fu scosso neppure dalla vittoria navale degli Stati cristiani nella battaglia di Lepanto del 1571, e dall’infuriare della pirateria barbaresca.
Paesi non rivieraschi e Mediterraneo

La Macroregione Mediterranea storicamente non è costituita solo da Paesi rivieraschi ma vivono in essa tradizioni e culture di Paesi non rivieraschi.
Sul finire dell’XI secolo il regno d’Ungheria con la conquista della Dalmazia settentrionale sboccò sull’Adriatico e restò parte integrante del Mediterraneo, sia pur in misura e in forme diverse, sino alla prima guerra mondiale. L’Austria a sua volta si era affacciata al Mediterraneo sin dal XIV secolo con il controllo di Trieste, sviluppatasi dal Settecento, e poi dell’intero Veneto, dal 1799 al 1866, e della Dalmazia.
Si può inoltre ricordare il possesso austriaco, non duraturo ma non per questo storicamente trascurabile, della Sardegna (1713-1720) e della Sicilia (1720-1737).
Nel Settecento le debolezze dell’Impero Ottomano favorirono le mire espansionistiche degli inglesi nel bacino occidentale , mentre la Russia mirava al bacino orientale e l’Austria tendeva al dominio dell’Adriatico.
Nell’Ottocento, durante le guerre napoleoniche, Francia e Gran Bretagna si scontrarono violentemente nel Mediterraneo, combattendo una guerra che vide gli inglesi prevalere e assicurarsi così il dominio incontrastato dei mari.
Sempre nell’Ottocento, la costruzione del canale di Suez rese possibile il collegamento del Mediterraneo all’Oceano Indiano e costituì un evento di fondamentale importanza per i commerci marittimi in quanto si evitava in questo modo la circumnavigazione dell’Africa per raggiungere via mare i ricchi mercati asiatici.
Una svolta di capitale importanza fu l’apertura del canale di Suez, costruito tra il 1859 e il 1869, il quale rese possibile per la prima volta collegare il Mediterraneo all’Oceano Indiano evitando la circumnavigazione dell’Africa.
La Gran Bretagna si impadronì nel 1878 di Cipro, la Francia allargò la sua influenza nell’Africa del Nord con l’annessione della Tunisia nel 1881.
Conflitti fra le potenze europee

La prima metà del 20° secolo vide il Mediterraneo investito dalle ambizioni e dai conflitti tra le potenze europee. La Germania da un lato aiutò gli Ottomani a mantenere la loro influenza sulle regioni mediterranee dell’impero, dall’altro cercò invano tra il 1905 e il 1911 di impedire la penetrazione della Francia in Marocco.
Nel 1912 l’Italia ebbe la sua colonia mediterranea con la conquista della Libia strappata ai Turchi. La fine della Prima guerra mondiale nel 1918 cancellò Russia, Austria e Turchia come potenze mediterranee e pose il Mediterraneo orientale sotto il dominio di Gran Bretagna e Francia.
Il processo di decolonizzazione ha mutato completamente nell’età della ‘guerra fredda’ lo scenario del Mediterraneo.
Situazioni, sensibilità, interessi diversi
Vi sono casi di mediterraneità storica: del Portogallo, a nord, e della Giordania a sud. Per il Portogallo valgono la sua appartenenza alla penisola iberica, che può esser considerata mediterranea nella sua interezza, ma soprattutto la sua realtà storica complessiva, pur se il destino più alto e più originale del Regno Portoghese è stato segnato dalla sua proiezione oceanica. Per la Giordania la sua attuale realtà politica, oltre che la storia la legano agli altri paesi arabi mediterranei.
Il filo unitario è trovato nel lungo processo storico di compresenza nello spazio mediterraneo, nella varietà sterminata di scambi, influenze, reciproci trasferimenti di cultura materiale e di patrimonio intellettuale.
Unione Europea e partnership euro-mediterranea

L’avvento dell’Unione Europea ha sviluppato via via, dagli accordi bilaterali con i paesi della riva sud del Mediterraneo al partenariato euro mediterraneo, il processo politico istituzionale di cooperazione nel quadro mediterraneo. L’Unione Europea avvia la costituzione del Soggetto Mediterraneo con la Dichiarazione di Barcellona del 24 novembre 1995.
Nel 1995 i quindici paesi europei, allora membri dell’Unione Europea, resero partecipi della politica mediterranea dodici paesi terzi (Turchia, Malta, Cipro, Israele e otto paesi arabi, cioè i sette rivieraschi e inoltre la Giordania) che risposero entusiasticamente.
Un salto di qualità nella storia del Mediterraneo rispetto alla precedente politica dell’Europa istituzionale, dunque della Comunità Economica Europea dal 1957, verso i paesi ‘non europei’ del Mediterraneo. Sin dall’inizio infatti l’Europa ebbe l’esigenza di regolare i propri rapporti con i paesi mediterranei perchè posti in particolari condizioni di vicinanza e di interdipendenza con essa.
Una storia del Mediterraneo è storia svoltasi in un vasto spazio, costituita nella sua essenza dall’incontro e confronto fra popoli e paesi di culture e civiltà diverse, la cui vicenda è stata segnata da una complessiva costante e profonda interdipendenza che mira, nelle sue diramazioni, a trovarsi in unico Soggetto Mediterraneo.
La Macroregione Mediterranea quale Soggetto voluto dalla Storia

La storia del Mediterraneo non può ricostruirsi e spiegarsi considerando soltanto le vicende marittime e della regione costiera, da Tripoli (1510) a Rodi (1522), a Tunisi (1535), Prevesa (1535), Algeri (1541), sino all’assedio di Malta e alla battaglia di Lepanto (1571), senza considerare congiuntamente gli scenari continentali, dall’Egitto (1517) a Mohacs (1526), nella pianura ungherese, e poi da Candia (1644-1669) a Vienna (1683) e così via sino a tutta la ‘questione d’Oriente’ e poi l’inizio e l’estendersi delle conquiste coloniali europee, dall’Algeria (1830) all’Egitto (1882), passando attraverso la vicenda del canale di Suez, nella quale paesi come la Francia e l’Austria, ebbero parte rilevante.
Al di là di ogni distinta epoca e specifica vicenda e degli aspetti politici ed economici, l’unità storica del mondo mediterraneo si palesa con piena evidenza in tutta la sua portata, nella storia religiosa, filosofica, intellettuale e artistica dei paesi della regione europea, presa nel suo insieme.
Le considerazioni geografiche, geopolitiche e storiche ci conducono verso la visione di un mondo mediterraneo che chiede il suo Soggetto istituzionale che è l’unico valido quadro per una prospettiva di dialogo, cioè di distensione, comprensione, rispetto e apprezzamento, fra popoli, culture e Civiltà mediterranea. Il fondamento di questo dialogo è nel riconoscimento di una unità inscindibile del mondo mediterraneo, unità non mitica e retorica, e fondata sulla evidente diversità di natura e condizioni geografiche, etniche, demografiche, economico sociali e così via, sulla molteplicità e diversità di culture e tradizioni che pur si riconducono a un processo storico unitario, sì che ciascuna può riconoscere se stessa e tutte le altre come componenti di quel processo, a pari titolo e con pari dignità.
Strategia dell’Unione Europea nel Bacino Mediterraneo

L’Unione Europea ha sempre guardato con particolare interesse al Bacino del Mediterraneo, sia perché esso, disegnando tutto il confine meridionale dell’Unione, rappresenta un area nella quale è indispensabile mantenere dei rapporti di stabilità e pacifico interscambio, e sia perché, dopo la caduta negli anni ottanta del secolo scorso della strutturazione a blocchi contrapposti, si erano aperte, proprio in quest’area, nuove possibilità di dialogo e di interrelazioni, specie tra gli Stati frontalieri, spesso con tradizioni storico culturali e identitarie affini.
Fino ad ora, tutte le strategie politiche messe in atto dall’U.E. nel Bacino del Mediterraneo, avevano sempre visto una prevalenza gerarchica dell’Unione attuata mediante un rapporto di tipo bilaterale sia nei confronti degli Stati Membri meridionali, che nei confronti dei Paesi non Membri della sponda sud.
Si è evidenziata la necessità di creare strumenti strategici capaci di implementare l’integrazione tra popoli mediante una comunicazione il più possibilmente diretta. Via via è maturata l’idea che il modello sussidiario, a cui è approdata l’Unione Europea, potesse ancor meglio esprimersi, dal basso, nel Mediterraneo con la democrazia partecipata.
Nel frattempo il Trattato di Riforma di Lisbona (ratificato nel 2007 ma messo in atto nel dicembre 2009) varava le strategie macroregionali con l’istituzione di ben 5 Macroregioni, tutte posizionate lungo i confini della Unione.
La Macroregione Mediterranea verso l’approvazione della Strategia Mediterranea
Di queste 5 Macroregioni, quattro stanno funzionando molto bene (Macroregione Baltica; Macroregione Danubiana; Macroregione Alpina; Macroregione Adriatico Ionica). Solo la Macroregione Mediterranea è in attesa del varo della Strategia.
Per permettere il migliore funzionamento delle Macroregioni, il Trattato di Lisbona, confermando quanto già stabilito dal Trattato di Maastricht, ha basato la ripartizione delle competenze sul Principio della Sussidiarietà, secondo il quale occorre che le decisioni siano adottate più vicino possibile ai Cittadini.
Ultimi passi e presente

A) Iter per la Macroregione Mediterranea:
Le tappe principali dell’iter per la Macroregione Mediterranea sono state:
a) 13 Luglio 2008: Conferenza di Parigi dell’Unione per il Mediterraneo.
Si è tenuta a Parigi la Conferenza dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), che ha visto la partecipazione di rappresentanti di 43 Paesi del Mediterraneo (con l’unica assenza della Libia).
b) 2010: “Dichiarazione di Palermo” 20 Stati, con i rappresentanti della Lega Araba, della Commissione Ue, del Comitato delle Regioni, del CRPM (Conferenza delle regioni marittime) “propongono di pervenire al più presto alla costituzione di una “Macroregione mediterranea”, preparata da un tavolo tecnico permanente, in analogia a quella già avviata intorno al Mar Baltico, come indicato anche dai pareri 2009/C – 272/08 – 318/02 del CESE, dalla Comunicazione 248/4 della Commissione europea, dalla proposta di risoluzione del Parlamento Europeo 2009/2230 –. “La Macroregione assicurerà la governance di una strategia comune, mediante il coordinamento e la valorizzazione di tutte le reti e le articolazioni già esistenti o che si possono costituire fra le Istituzioni, le comunità locali e le forme organizzate della società civile”.
c) 2012: pareri delle Commissioni del Parlamento Europeo:
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L’ISTRUZIONE (2 marzo 2012) che, al punto 6 e 7, “insiste sull’importanza del bacino del Mediterraneo come spazio di cooperazione decentrato, che va oltre i rigidi confini geografici, per rafforzare il processo decisionale transregionale e la condivisione di buone pratiche, non da ultimo per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, l’ecologia, lo sviluppo economico, l’ecoturismo nonché i partnerariati a livello di cultura, ricerca, istruzione, gioventù e sport”; “sottolinea l’importanza specifica dell’istruzione quale catalizzatore per una transizione democratica”; afferma che “la Macroregione Mediterranea debba svilupparsi in conformità con la normativa internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” e la “Convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”; inoltre, al punto 10, “sottolinea che la Macroregione Mediterranea agevolerebbe il dialogo interculturale e l’arricchimento del patrimonio culturale comune dell’Unione europea, mobiliterebbe la società civile e incoraggerebbe pertanto la partecipazione delle ONG e delle popolazioni del Mediterraneo ai programmi culturali e educativi dell’UE”.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI (19 marzo 2012) che, al punto 6, “ritiene necessario, al fine di attuare una strategia macroregionale per il Mediterraneo, basarsi sull’esperienza e sui risultati raggiunti”; inoltre, ai punti 8 e 9, si “sottolinea che le principali aree di intervento per la Macroregione del Mediterraneo dovrebbero essere mirate agli opportuni livelli sub-regionali per la cooperazione su progetti specifici e comprendere le reti energetiche, la cooperazione scientifica e l’innovazione, le reti per la cultura, l’istruzione e la formazione, il turismo, il commercio, la tutela ambientale, il trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento, dal sovra sfruttamento e dalla pesca illegale attraverso la creazione di una rete integrata di sistemi di informazione e sorveglianza per le attività marittime, il rafforzamento del buon governo e una pubblica amministrazione efficiente, in modo da favorire la creazione di posti di lavoro; ritiene che sia importante, in particolare dopo gli eventi della Primavera araba, che la nuova macroregione contribuisca alla definizione di una nuova strategia con i paesi terzi per la corretta gestione dei flussi d’immigrazione e dei benefici reciproci derivanti da una maggiore mobilità, basata su una strategia con i paesi terzi di lotta contro la povertà e di promozione dell’occupazione e del commercio equo, contribuendo così alla stabilità nella Macroregione”.
d) 3 luglio 2012: RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO (pubblicata il 29 novembre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) sull’evoluzione delle strategie macroregionali dell’UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo che, ai punti 1 e 2, ritiene che “le strategie macroregionali abbiano aperto un nuovo capitolo nella cooperazione territoriale europea applicando un approccio dal basso verso l’alto ed estendendo la cooperazione a un numero sempre crescente di settori grazie a un uso migliore delle risorse disponibili; raccomanda che le strategie macroregionali, visto il loro evidente valore aggiunto a livello europeo, ricevano maggiore attenzione nel quadro della cooperazione territoriale europea che sarà rafforzata a partire dal 2013; ritiene che questo tipo di cooperazione territoriale sia utile, in particolare laddove le frontiere hanno frammentato tali spazi nel corso della storia, e possa favorire l’integrazione dei nuovi Stati membri e delle loro regioni; inoltre, ai punti 16 e 17, “si ritiene che una strategia macroregionale mediterranea che associ l’Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le organizzazioni regionali, le istituzioni finanziarie e le ONG della sponda europea del bacino del Mediterraneo e dell’Unione per il Mediterraneo, e che sia aperta ai paesi vicini e/o ai paesi in fase di preadesione, sia in grado di innalzare notevolmente il livello politico e operativo della cooperazione territoriale in questa zona; sottolinea l’importanza di basarsi sull’esperienza, sulle risorse esistenti e sui risultati raggiunti dalle organizzazioni regionali esistenti; si sottolinea che la Macroregione del Mediterraneo garantisce che i vari programmi dell’UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicenda e che i finanziamenti esistenti siano utilizzati nella maniera più efficace possibile, e potrebbe apportare un reale valore aggiunto ai progetti concreti dell’Unione per il Mediterraneo e associare i paesi terzi e le regioni interessati fin dalla fase di definizione della strategia, utilizzando a tale scopo lo strumento finanziario di vicinato e di partnerariato, sempre nell’assoluto rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, e promuovendo, ove necessario, il principio del “di più per chi si impegna di più”.
e) 10 e 11 dicembre 2013: Parere del Comitato economico e sociale europeo C.E.S.E:
“La macrostrategia per il Mediterraneo deve puntare a trasformare la regione in uno spazio veramente all’avanguardia in termini di scambi commerciali, turismo, civiltà, idee, innovazione, ricerca e istruzione, convertendola in una regione di pace ai fini dello sviluppo e della prosperità sociale”.
“La macrostrategia per il Mediterraneo (suddivisa in due strategie subregionali) deve inserirsi nel quadro della strategia Europa 2020, dei programmi esistenti e dei meccanismi di agevolazione finanziaria dell’UE, e ricorrere a iniziative europee come il programma Interact per la fornitura di assistenza tecnica e formazione. Andrà però creata una nuova struttura per gestire e agevolare il funzionamento delle istituzioni. La strategia macroregionale dovrà far nascere nuovi approcci che costituiscano un vantaggio per i paesi coinvolti, con la prospettiva di misure pratiche e di politiche da poter applicare con successo”.
f) 2013-2018: Si strutturano le spinte coesive secondo la normativa europea.
Il 28 settembre 2017 un’ulteriore spinta viene dal parere della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza ambientale che “ribadisce nuovamente il proprio sostegno all’attuazione di una strategia macroregionale per il bacino del Mediterraneo”, anche per contrastare rischio di catastrofi naturali e l’inquinamento mediterraneo e chiede al Consiglio e alla Commissione di agire rapidamente per la strategia macroregionale mediterranea.
g) Si procede così, nel rispetto delle Procedure, alla formalizzazione dell’Assemblea della Macroregione Mediterranea che verifica positivamente i suoi poteri il 9 novembre 2018.
B) Iter della Macroregione Mediterranea:
Le tappe principali dell’iter della Macroregione Mediterranea sono state:
a) 9 novembre 2018: l’Assemblea della Macroregione Mediterranea nomina unanimemente l’Amministrazione Pubblica procedente: il Difensore Civico campano.
b) Successivamente: varata la Sede Macroregionale in Napoli (Palazzo Berio); varata la segreteria organizzativa; consolidato il decreto di riconoscimento per assenze di impugnativa; varato il sistema di domande e risposte (FAQ); varato il Documento per azione macroregionale; aperto il Sito Web; varato il Parlamento Mediterraneo; varata la Struttura della Macroregione Mediterranea; varata, previa consultazione, la Strategia della Macroregione Mediterranea.
c) Sulla base della “Guida alle strategie macroregionali dell’Unione Europea (21 aprile 2017)” e dei processi attuativi in corso, la Macroregione Mediterranea va ogni giorno avanti e le due fasi sono:
A) la conclusa FASE DELLA COSTITUZIONE E FORMALIZZAZIONE;
B) la FASE DELLA STRATEGIA;
………………………..
A) La FASE DELLA COSTITUZIONE E FORMALIZZAZIONE si è conclusa e ha comportato:
– avvii e censimenti degli avvii macroregionali;
– chiamate a raccolta aperta e trasparente di ogni realtà disponibile del Mediterraneo senza preclusione e senza veti;
– istituzione formale dell’Assemblea della Macroregione Mediterranea;
– convocazione aperta con criteri trasparenti di ciascun Action Group;
– incardinamento e incorporazione degli Action Group nell’Assemblea della Macroregione Mediterranea;
– verifica oggettiva di ogni istanza partecipativa con revisione degli Action Group;
– costituzione di Ufficio di Presidenza dell’Assemblea della Macroregione Mediterranea;
– preverifica dei poteri;
– verifica dei poteri della stessa Assemblea della Macroregione Mediterranea con esame di ogni possibile rilievo;
– constatazione unanime di nessun rilievo;
– discussione, aperta al pubblico, delle modalità di formalizzazione;
– esame motivato, trasparente e pubblico di ogni aspetto con presenza di mass media;
– acquisizione di proposta unica di panel;
– scelta condivisa di Amministrazione Pubblica procedente da parte di Action Group della
Macroregione Mediterranea;
– atto formale di scelta motivata dell’Amministrazione Pubblica procedente (Difensore Civico presso la Regione Campania) unanimemente da parte dell’Assemblea della Macroregione Mediterranea;
– decreto dell’Amministrazione Pubblica procedente (che chiude la FASE DELLA COSTITUZIONE E FORMALIZZAZIONE).
B) La FASE DELLA STRATEGIA è costituita da 25 ulteriori step e sono stati completati i primi 24 step, come di seguito riportati:
– il varo delle Procedure per Organi della Macroregione Mediterranea (sei step);
– l’istituzione e la costituzione di Sede Macroregionale (due step);
– l’istituzione e la costituzione di segreteria organizzativa della Macroregione Mediterranea (due step);
– la pubblicazione su Bollettino Ufficiale del decreto formale;
– il consolidamento dell’atto formale (decreto) di Amministrazione Pubblica procedente prescelta, con avvenuto decorso del termine per ricorsi giurisdizionali e amministrativi, anche straordinari;
– l’esame dei contributi comunque provenienti (tre step);
– il sistema, costantemente aperto, di domande e risposte (FAQ) (tre step);
– la Strategia per azione macroregionale, a seguito di consultazione (tre step);
– l’apertura del Sito web della Macroregione Mediterranea;
– l’istituzione, nel rispetto delle Procedure, della Struttura della Macroregione Mediterranea.
SIAMO ORA, in conclusione, verso la Strategia macroregionale.
I principali venti ultimi obiettivi raggiunti a fine 2022 e nel primo bimestre 2023 dalla Macroregione Mediterranea sono:
1. Deliberazione unanime di Parlamento della Macroregione Mediterranea di approvazione di bilancio;
2. Istituzione e apertura delle Sedi istituzionali mediterranee (Malta, Albania, Libano; Iraq) con relativi Responsabili e due Sedi operative per gli Organi in Napoli;
3. Cooperazione con Sportello Unico Internazionale della Difesa Civica, e suo nuovo Statuto tradotto nelle cinque lingue;
4. Completamento e stabilizzazione dell’Incaricogramma della Macroregione Mediterranea in cui si può sempre entrare ma con Procedura di rinnovo sostitutivo;
5. Deliberazione unanime assembleare di nomina di Amministrazione procedente nello Sportello Unico Internazionale della Difesa Civica;
6. Approvazione unanime assembleare del documento Stabilità, certezza, concretezza con i relativi documenti dell’Unione Europea.
7. Comitato Stati-Regioni del Mediterraneo, completato e operativo;
8. Rapporti con altre quattro Macroregioni;
9. Presa d’atto del Parlamento Europeo;
10. Notificazione a tutti i Premier e tutti i Presidenti di Regioni del Mediterraneo, con positivi riscontri nel Comitato Stati-Regioni;
11. Definiti e sistematizzati Beni Culturali di Valore Mediterraneo, per ogni Stato, con ogni Referente;
12. Conferma di Strategia con i quattro Pilastri, pubblicata previa consultazione in tutto il Mediterraneo, esami dei contributi, riscontri motivati, nessuna contestazione, approvazione.
13. Inaugurate Sedi istituzionali nel Mediterraneo (Malta, Libano, Albania, Iraq), con relativi servizi fotografici;
14. Sedi di Parlamento e di Governance, varate e formalizzate e in piena operatività;
15. Dopo l’approvazione del Bilancio della Macroregione Mediterranea assegnazioni correlate.
16. Nuova Carta intestata con logo e Sede centrale di Malta;
18. Assicurati e formati gli Uffici di Relazioni delle Sedi;
19. Vidimata disciplina per Aree mediterranee con procedura di Timbro ufficiale con logo e scritta in inglese (MEDITERRANEAN MACROREGION);
20. Varati gli Obiettivi Pilota con relative Equipes, con Protagonisti partecipanti e con Programma dettagliato, temporalizzato e operativo; le attività degli Obiettivi Pilota iniziano il 15 marzo 2023.
L’Organizzazione attuale
La Struttura della Macroregione Mediterranea, articolata in Action Groups, è l’Organizzazione dirigenziale e gestionale della Macroregione Mediterranea ed è costituita dai Responsabili degli Uffici e delle Redazioni della Macroregione Mediterranea, secondo le Procedure della segreteria organizzativa, come da Mozione unanimemente approvata dall’Assemblea istitutiva della Macroregione Mediterranea e recepita nel decreto della nominata Amministrazione procedente. La Struttura della Macroregione Mediterranea realizza gli obiettivi della Macroregione Mediterranea. La delega nel modello partecipativo e meritocratico della Macroregione Mediterranea non è prevista e quindi non vi sono delegati. Nelle Procedure Macroregionali nessuno (Stato, Regione, Organismo pubblico o privato) ha diritto di veto o di avere delegati ma solo di proporre persone con i requisiti per partecipare a Procedure.
La partecipazione macroregionale si estrinseca con la possibilità meritocratica di ciascuno di accedere a tutti i ruoli della Struttura e di sviluppare nei massimi ruoli tramite Procedure. Ai ruoli della Macroregione Mediterranea si accede e nei ruoli ci si sviluppa per Procedure (non per delega, rappresentanza o elezioni). A tutti i ruoli si accede tramite apposite Procedure e tutti i ruoli si sviluppano tramite apposite Procedure. L’Assemblea giovedì 20 ottobre 2022 ha nominato unanimemente la nuova Amministrazione procedente nello Sportello Unico Internazionale della Difesa Civica.In ogni ruolo vanno rispettati gli specifici Standard e per sviluppare nei ruoli superiori vanno rispettati gli Standard superiori. Le attività sono attribuite e i ruoli sono affidati con Procedure di democrazia partecipata e meritocratica che non è un metodo partitico né elettivo bensì è basato sugli Standard rispettati.Il modello della democrazia partecipata e meritocratica (dare di più a chi dà di più) rende impossibile ricoprire un ruolo senza rispettare gli Standard dello stesso ruolo perché, in tale modello, il ruolo coincide con gli Standard relativi. In altri termini per continuare a ricoprire un ruolo bisogna continuare a rispettare i relativi Standard e per sviluppare in un superiore ruolo bisogna rispettare i superiori relativi Standard.

